Emanuele Sica, con Memorie di una Janara (Delta3Edizioni), contestualizza un mondo addossando principalmente alla donna il destino di essere essa stessa strega e, in quanto tale, la rovina dei suoi uomini. Ma l’Autrice in questo libro racconta anche altro. Fin dall’inizio infatti ci porta a pensare che le donne nascono con la magia addosso. Che però sono per natura anche raccoglitrici, guaritrici, levatrici, cioè figure capaci di guarire ma allo stesso tempo anche capaci di ammaliare genti dotate di scetticismo. Che in quanto streghe e libertarie sanno di appartenere non all’uomo quanto a loro stesse o nei casi limiti al demonio. Il dato storico è che durante tutto il Rinascimento un gran numero di loro sono state inquisite, condannate, alcune bruciate vive sul rogo. Non di meno sono le “fatture del male”; si cita qui a caso quella del malocchio, che recita così: Occhio e controcchio verricello all’occhio, crepa l’invidia e scatta il malocchio, che, tenendo in mano una candela accesa, una volta esercitata sul malcapitato, si rischiava di portarlo alla pazzia o addirittura alla morte. Ma, come si accennava prima, Emanuela Sica, in questo libro sulle Janare, fa cenno al casuale ritrovamento, in una vecchia casa di campagna, abbandonata da anni, detta “a Li Pacci”, di un antico manoscritto intitolato appunto Memorie di una Janara, che l’Autrice finisce per leggerlo insieme ai suoi due figli Ginevra e Michele. Quando si stava raccolti intorno al focolare, quando le nonne trascorrevano ore e ore ad allargare la lana per ridare morbidezza ai materassi, quando ci si ritrovava di sera per scegliere le castagne oppure sotto la luna a svrzare ‘o grarignulu, quando nel mese di giugno si facevano ‘e ‘nzerte” r’agghi, quando in luglio si preparava l’infuso del nocino, quando in primavera si sarricava per ridare respiro alle colture infestate dalle erbacce, quando si jeva a mete lu granu o ci si organizzava per la trebbiatura, eccetera, quelli erano tutti momenti a cui la globalizzazione disumanizzante, come qualcuno ha definito l’attuale corso della storia, ha portato via l’anima. L’Autrice sapientemente quindi ci spiega cosa è rimasto in noi soprattutto nei giovani di oggi se non il nefasto retaggio-miraggio di tutti questi personaggi. Alcuni, ovviamente, essendo essi stessi simbolo della paura ancestrale, vuoi per la profondità di tutto ciò che sa di occulto, vuoi per le sue alte fantasie, rappresentano le tante figure simboliche che popolano l’immaginario collettivo di Guardia Lombardi e dell’intera Irpinia. Il suo processo di personificazione e chiudo inizia col dare un nome reale ai personaggi, con chiaro riferimento all’universo femminile, in quanto donna e madre per antonomasia vuoi anche per le sue caratteristiche fisiche. Nell’immaginario sono tutti personaggi vissuti ai margini dei pozzi, dei fiumi, dei torrenti, sempre in agguato, pronti a rapire l’imprudente, lo spavaldo, il timoroso, tutti quelli che avessero osato addentrarsi nei vari ambienti familiari. Sin da piccoli, infatti, in caso ci si avvicinava ai bordi di un pozzo, al parapetto di un ponte o agli argini di un fiume vi era sempre qualcuno che provvedeva a metterci in guardia del pericolo, in quanto il solo sporgersi poteva significare sparire per sempre nelle profondità delle lune piene o cadere nelle lunghe braccia di questa snella e agile figura dai fluenti capelli neri, della Janara, appunto. In un passato non troppo lontano, quando la luce elettrica ancora non illuminava le case, quando ripidi scalandroni in legno collegavano i piani abitati alle soffitte buie e misteriose, quando strette botole al culmine di quegli scaloni erano la porta di un mondo parallelo, un personaggio senza età, tipo uomo-bambino, scorrazzava incontrollato e indisturbato per i sottotetti per poi, complice la notte, sparire. Passi felpati spaventavano gli abitanti nelle notti d’inverno, intimità domestiche che venivano violate, bambini che al risveglio dicevano di essersi ritrovati accanto a figure umane senza età: un poco tutti questi personaggi venivano a noi presentati come una sorta di spiritelli bruttini e dispettosi, tutti con lo spirito di farci paura! Opera di altissimo livello sia storico, sia poetico, in quanto in questo libro ci trovo tanta poesia, e sia per le sue complesse esposizioni, questa della Sica, a mio avviso tutto quanto va oltre il concetto di tutela e di conservazione delle tradizioni; per questi ed altri motivi chiudo convinto che l’autrice sia riuscita a mettere in luce leggende e appunto tradizioni di vita quotidiana che non appartengono solo a noi irpini quanto alla storia stessa del Mezzogiorno.

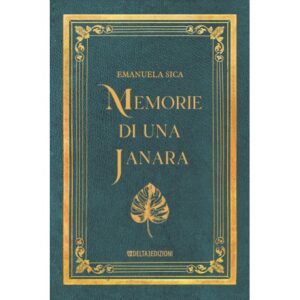
Grazie Ottaviano, per questa accurata e profonda recensione che mi onora anche perché pubblicata su una vetrina di poesia così importante e internazionale.
Thanks for the beautiful summary of Emanuela’s book. She is a very talented woman, dedicated to her family and Guardia Lombardi.