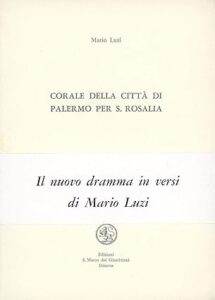LUZI: CORALE PER SANTA ROSALIA
Per le genovesi edizioni San Marco dei Giustiniani, nella collana diretta da Giorgio Devoto, vede luce nel 2025, a cura di Aldo Gerbino, la II edizione del volume di teatro-poesia “Corale della Città di Palermo per S. Rosalia” di Mario Luzi. La I edizione, del 1989, registrava un’introduzione di Stefano Verdino ed una nota dello stesso Luzi che son presenti nella II ed. nell’Appendice del volume. Il testo luziano, promosso dalla Università degli Studi di Palermo in occasione del 400° anno rosaliano, porta una prefazione del Magnifico Rettore Massimo Midiri. Tra gli altri interventi: quello di Michelangelo Gruttadauria, presidente del Sistema Museale dell’Università e le immagini di Rosalia a firma dell’artista Gaetano Lo Manto. Il saggio introduttivo di Aldo Gerbino, di cui offriamo uno stralcio, porta il titolo, tratto da un verso di Mario Luzi, “Io, nella mia mandorla di roccia”:
Non v’è dubbio che la strumentazione verbale nella pratica drammaturgica luziana, in cui appare cogente la sua sorgiva poesia (sin dalle traduzioni: da Shakespeare a Racine a Coleridge), si va ininterrottamente dipanando in quel reticolo unitario di linguaggio secreto nella pregnanza del teatro di poesia: da Ipazia a Rosales, da Histrio fino agli obbiettivi centrati su d’una Sicilia, notoriamente in affetto a Luzi: dal Corale che fa da cornice alla figura di Santa Rosalia all’orrore dell’assassinio restituitoci con Il fiore del dolore in cui campeggia il martirio di Padre Pino Puglisi, il tutto permeato da quel desiderio di pace, «di sguardi penetranti, incisivi e rigorosi, e insieme accorati» sondati da Marco Marchi per le poesie civili, così vogliosi di speranza e «tesi costantemente a coniugare terrestre e celeste». Mario Luzi, introducendo un testo teatrale, accenna a quel ‘desiderio di sospirata unità’ che coinvolge gli esercizi della poesia e del teatro. In particolare, egli chiarisce ‒ e ciò non può che riflettere la destinazione della sua stessa scrittura ‒ in che modo l’ossessiva penetrazione del «rovello» creativo, essenziale motore della poesia, non sia altro che il medesimo tormentoso pensiero che ritroviamo «interno all’ideazione e al linguaggio», in quanto nel dramma esso risulta «oggettivo, anzi incarnato, e proiettato contro il mondo esterno e le sue istituzioni». Tale affermazione induce a riflettere proprio sul come l’ampia geografia poetica, irradiata dalle drammatiche asperità del mondo, si ponga caparbiamente sintonica alle ‘esperienze vissute’ e a quell’interezza della ‘vita psichica’ vagliata da Dilthey nella sua indefettibilità di registro esistenziale. È l’irrompere della poesia a mettere in ordine i fatti, articolarne le dinamiche affinché, come accade in Pirandello con la mediazione del critico teatrale di Resina Adriano Tilgher, possano essere mutati nel consistente viluppo di «atti drammatici» e così estenderne quell’interrogativa inerenza posta da Leonardo Sciascia per la quale debbono essere considerate «opere di poesia Così è (se vi pare), Il berretto a sonagli e l’Enrico IV». Orbene col riversare la veemenza popolare scossa dalle appenanti vicende del tempo, a piene mani sparse nel suo Corale della città di Palermo per S. Rosalia, Luzi traccia un atto letterario drammatico sorretto dal discusso resoconto del gesuita Giordano Cascini, ma non disgiunto da quel piacere di narrare e rivivere il più possibile, dal recondito delle pulsioni sociali, «un sentimento endemico e condiviso». Si ha di fronte un materiale verbale misurato nella espansione agonica e dialogica d’una allure metrica espressa in ottonari, settenari e rari endecasillabi, in cui s’avverte limpidamente quel rovello di cui si è fatto cenno, qui moltiplicato in tessere musive, in gemme iconiche atte a puntellare atmosfere barocche, fruscii, mormorii e onomatopee, scatti d’anafore in una lingua toccata da qualche raro innesto dialettale, e ancora antropologici gridìi, forzosi ripiegamenti in cui fede e scienza si affannano a cercare più rispondenti simmetrie nel travaglio della storia che muta. Si coglie, in tale lavorio poetico, l’aspirazione sociale ad ospitare l’inaspettato e lenitivo cuneo d’umiltà offerto dall’epifanica figura di Rosalia in quel periodo compreso tra il XVI e il XVII secolo avversato dall’alternarsi di mortali epidemie, eventi bellici, urgenze del tessuto sociale mortificato da carestie, catastrofi naturali: condizioni di palese disagio innervate dalle ciniche insofferenze delle baronie in cui prendono avvio accelerazioni mutagene pronte ad investire, ricorda Fabrizio D’Avenia, le strutture portanti “della Monarquía católica degli Asburgo e la Santa Sede”. L’umiltà d’una obliata figura sacra si fa dunque strada per incarnarsi con insolita rapidità in Rosalia Sinibaldi, restituendo alla luce quel suo spazio d’esistenza (1130-1170), regnante ‒ tra venti di sedizioni ‒ Guglielmo I (detto il Malo), dove essa aveva dipanato l’incoercibile brama della scelta anacoretica per essere una sommersa vagola particella nel fundus mistico della suprema dedizione celeste. Coronata dal proprio combusto sacrificio vive del suo stesso ardere e ‒ nell’accezione propria del termine olocausto ‒ farsi, in similitudine, foscolianamente sacra ‒ per quel roccioso essere un tutt’uno con la sua tomba dimodoché, dal luziano sasso, muoversi irreversibilmente con il suo popolo verso il Volto divino.